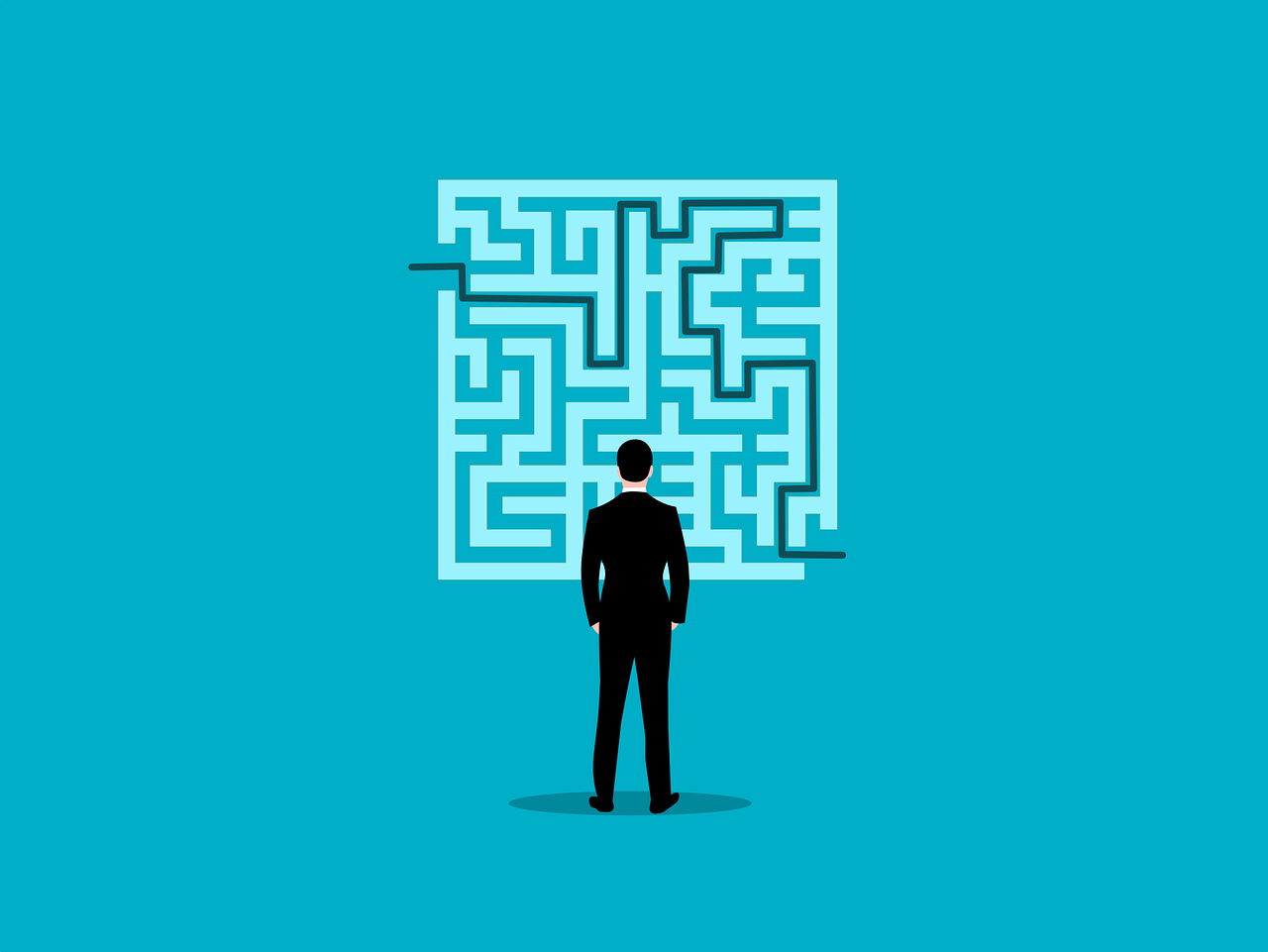
Lavorare è fonte di gioia, da condividere insieme: il seminario Asfor-Isvi alla Cattolica di Milano
"Verso un nuovo senso del lavoro" è il titolo scelto per il seminario organizzato da Asfor e Isvi lo scorso 21 novembre all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ricchissimi gli spunti di riflessione proposti dai protagonisti della intensa mattinata.
di Alessandra Cicalini

Da vera vocazione dell’uomo ad attività collaterale nella nostra vita: è questa la trasformazione in atto nel mondo del lavoro, focus del seminario organizzato dall’Associazione Italiana per la formazione manageriale lo scorso 21 novembre all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A dirlo, sono innanzitutto i dati contenuti nella pubblicazione “Verso un nuovo senso del lavoro”, curata dall’Asfor con l’Istituto Valori d’Impresa, presentati in apertura di mattinata dal presidente Asfor, Marco Vergeat.
Suddiviso in tre parti, nella prima il volume si sofferma sulle fonti ufficiali che disegnano con i numeri le dinamiche in atto nel mercato del lavoro italiano. Cuore della seconda è l’analisi demoscopica delle aspettative emergenti espresse dalle persone attualmente occupate. La terza e ultima parte è più di tipo qualitativo e contiene interviste e focus group ruotanti intorno al significato del lavorare oggi.
In primo luogo, dopo il picco occupazionale toccato nel 2022, attualmente nel nostro Paese le persone al lavoro sono «24 milioni sui 38 milioni di persone attive in totale», esordisce Vergeat.
In discesa, analogamente, è il tasso di disoccupazione, pari al 6,8%.
All’apparenza incoraggianti, i dati sopra descritti sono però parzialmente corretti in negativo dal tasso di inattività che in Italia continua ad essere tuttora molto elevato: «Siamo penultimi in Europa», precisa Vergeat, che sottolinea il legame del fenomeno con l’ancora molto consistente presenza di Neet e un’altrettanto ancora bassa occupazione femminile.
Qualche segnale di speranza arriva dall’aumento del lavoro stabile, che oggi si traduce in oltre 15 milioni di lavoratori assunti a tempo indeterminato. Restano però forti le fragilità strutturali tipiche del nostro Paese, con circa 5 milioni di persone assunte con contratti precari, di cui molte sono giovani e donne.
Un’altra criticità del sistema Italia è data dal tasso di occupazione dei giovani adulti, scesa per via dell’inverno demografico che stiamo attraversando, in verità non solo nel nostro Paese.
Al contrario, sono in aumento gli occupati senior, ossia i lavoratori della fascia tra i 50 e i 64 anni, cresciuti nel solo 2022 di quasi il 41%. In compenso, la RAL media annuale degli italiani è calata dal 1990 al 2020 di quasi il 3%.
Ai dati numerici secchi fanno seguito le percentuali snocciolate da Vergeat per inquadrare la percezione che i connazionali hanno del lavoro oggi. La stragrande maggioranza mostra una relativa soddisfazione per l’impiego presente (pari all’82,3%), ma una significativa insoddisfazione per il futuro (55,3%).
Le incertezze sul domani sono probabilmente all’origine di una diversa importanza data in generale al lavoro, non più in cima ai desideri degli italiani. Molto più centrali sono gli aspetti immateriali legati alla propria vita attiva, a partire dalla qualità delle relazioni con i colleghi.

Secondo lo studio Asfor – Isvi, in questo cambiamento di prospettiva ha giocato un ruolo determinante la pandemia da Covid 19, che tuttora esercita la sua ombra lunga nella crescente richiesta di remote working, una modalità sperimentata come obbligo in quella fase e che invece adesso è vissuta un po’ come il simbolo del migliore bilanciamento vita – lavoro.
Il legame tra spirito del tempo e immaginario collettivo racconta insomma di una grande porosità nei confini tra ciò che sta dentro e sta fuori dall’impresa. L’incertezza regna sovrana, come si vede dal continuo alternarsi di riprese e cadute improvvise, che si sono susseguite dalla pandemia in poi (guerre, ripresa del dibattito sul nucleare, e così via).
«Il futuro attrae poco», prosegue Vergeat, il che porta a un grande schiacciamento sul presente.
In questo scenario si inserisce anche l’ingresso potente dell’intelligenza artificiale generativa nelle nostre vite, origine di sentimenti contrastanti, di fascinazione, da una parte, e di preoccupazione, dall’altra.
In generale, l’esperienza del lavoro è molto più «virtualizzata» con ricadute anche sulla qualità di ciò che si fa. Secondo Vergeat, infatti, «l’iperconnessione sottrae energie all’approfondimento e alla riflessione».
Per molte persone è in altri termini diventato difficile «sostare», in un task o direttamente in un luogo di lavoro. E’ un po’ come se si dicesse a se stessi: fuori di qua, dal luogo che mi sta dando uno stipendio, «c’è molto altro che non si può perdere», spiega ancora il presidente di Asfor.
Il fenomeno colpisce soprattutto le generazioni più giovani, che «faticano a stare dentro progetti di lungo periodo o su un tema complesso», sostiene la ricerca.
Questo tipo di irrequietezza è cioè meno avvertita da Baby Boomer e GenX, che si differenziano moltissimo da Millennial e GenZ nel ruolo attribuito in generale alle organizzazioni: «Per i lavoratori più anziani l’onere della prova è su loro stessi – prosegue Vergeat – mentre per i più giovani è l’organizzazione che deve meritarsi i lavoratori».

Va da sé che il dialogo tra le varie generazioni al lavoro diventa molto più accidentato, anche per il fatto che spesso sono proprio i senior ad esprimere «un giudizio sommario» sui junior.
C’è anche da dire che nella dinamica di alcune carriere – ad esempio nella sanità – occorrono competenze altissime che vanno acquisite in tempi più lunghi, ma non sempre i giovani sanno aspettare.
In più, quella maggiore richiesta di buone relazioni con i colleghi spesso si traduce in un generico bisogno di «un po’ di tepore», che non ha niente a che fare con l’idea di fare davvero squadra con gli altri.
Nelle aziende di oggi si parla insomma sempre di più di “purpose” e di condivisione di valori più generali da parte di tutti, ma come si possono davvero affermare se per il singolo ciò che più conta è «domani mattina»?
A una domanda del genere non si poteva che rispondere con ulteriori quesiti lanciati nel panel successivo della mattinata di studio, coordinato da Giorgio Colombo, vicepresidente vicario di Asfor. I primi li ha formulati Stefania Contesini, coordinatrice della Philosophy and Business Unit e del Laboratorio Filosofia Impresa – Università Vita Salute San Raffaele.
La studiosa si è soffermata in primo luogo sul valore del lavoro nella storia della filosofia, ricordando come nell’antichità sporcarsi le mani, la cosiddetta praxis, era considerato degradante. L’unica parola presa in considerazione era la “poiesis”, ossia l’agire politico e sociale, che trovavano «un senso e un fine in se stessi», spiega Contesini, che aggiunge come in questo modello, ripreso da Jurgen Habermas, «il lavoro non realizza veramente l’umano».
Con John Locke e poi con Hegel e il giovane Marx si è fatta strada un’altra visione, che definisce il lavoro «espressione di se stessi e base per costruire legami sociali».
Da questo momento in poi si comincia a parlare anche di patologie conseguenti a un cattivo vissuto nel lavoro, legato a doppio filo al fatto di attribuirgli un valore economico.
Oggi, come racconta lo studio Asfor – Isvi, gli occupati sono in aumento, ma «al contempo sono diminuite le ore lavorate», ha rimarcato Giorgio Colombo, che ha chiesto quindi a Contesini: «Allora il buon lavoro, inteso come lavoro dignitoso e significativo, qual è?».
La docente non poteva che rispondere allargando ulteriormente lo sguardo al senso generale del nostro vivere, alla maniera di Socrate, che si interrogava su quale fosse la vita davvero degna di essere vissuta.
Per poter rispondere a una domanda del genere, occorre partire da quella inversa e chiedersi «che cosa rende insensato il lavoro», precisa la studiosa, che cita non a caso il libro di David Graeber intitolato Bullshit Jobs. Nel testo si parla di mansioni considerate inutili, dannose o superflue, non tutte peraltro pagate poco.
La significatività si gioca insomma «su altri piani», rimarca Contesini, autrice del testo Fare impresa con i valori, che suggerisce di guardare al nostro lavorare da due prospettive, una etica e l’altra estetica.

Fare propria questa visione vuol dire riconoscere che «la persona non è semplicemente un recipiente da riempire», bensì qualcuno che è dotato di «una sensibilità da allenare al valore», aggiunge ancora la docente. Su questo aspetto molte aziende non sono troppo attente, precisa, mentre allenare pensiero critico e capacità di giudizio sono le premesse essenziali per rendere il purpose qualcosa di concreto e condiviso.
Sul significato della parola lavoro si è soffermata anche Ivana Pais, professoressa ordinaria di sociologia economica all’Università Cattolica del Sacro Cuore, declinandone anche le caratteristiche della rilevanza e del senso in generale.
A suo avviso, all’origine dell’interrogativo c’è il rovesciamento di prospettiva che si è verificato negli ultimi anni: «Prima guardavamo quasi esclusivamente alla domanda di lavoro. Oggi invece ci occupiamo dell’offerta», esordisce Pais. Il mutamento è letto dalla docente come una sorta di profezia che si è autoavverata: «Per anni è stato detto di non aspettarsi più il posto fisso? Bene: oggi nessuno se lo aspetta più», rimarca.
Come ridare senso al nostro lavorare, se tutto il resto è diventato più importante, come si è visto soprattutto dopo un evento “disruptive” come la pandemia? Secondo Pais, sono infatti proprio i momenti di crisi e di stop forzato che permettono di innescare i cambiamenti più profondi, come quello che stiamo attraversando adesso.
Solo nelle aziende che davvero si interrogano su come stanno i loro collaboratori la responsabilità sociale d’impresa diventa ben più di un’aspirazione. «Per i lavoratori di oggi le vacanze hanno un senso in sé», sottolinea la studiosa, che ha esaminato il fenomeno degli “slash workers”, ossia di coloro che sui social raccontano tutto ciò che fanno, in molti casi non per bisogni economici.
«Ho intervistato un dirigente che faceva il cuoco a domicilio – racconta Pais – il quale diceva: mi faccio pagare perché così ne ottengo un riconoscimento vero». Nel darci identità la remunerazione resta quindi importante, molto di più della sola stabilità, che invece a molte persone non basta più, osserva ancora la sociologa.
«Come tornare ad integrare nella dimensione del lavoro la gratificazione simbolica? », si domanda in conclusione Pais. Alla questione risponde idealmente Vittorio Coda, professor emeritus dell’Università Bocconi e Presidente del Comitato Scientifico dell’Isvi.
«Siamo sollecitati a riscoprire valori antichi», esordisce il professor, che rimarca come, in fondo, abbiamo sempre saputo che «il lavoro può essere anche gioia». Come mai si sono appannati questi antichi valori, allora?
Secondo Coda, ci ha messo lo zampino il neoliberismo che si è affermato a partire dagli anni Ottanta e Novanta, con la conseguente forte privatizzazione dell’economia. Secondo Coda, in un sistema del genere «le persone tendono a non essere considerate in quanto tali», bensì sono viste come «strumenti per massimizzare il profitto».
Ciò ha avuto riflessi anche sull’organizzazione interna delle imprese, in cui si è affidato agli HR di intrattenere i rapporti con i dipendenti in maniera sbrigativa, trincerandosi dietro agli obiettivi di budget.
Da un atteggiamento di questo tipo non poteva che derivarne una frattura insanabile. Come ricucirla? Prendendo «le distanze dalla cultura neoliberista», sostiene il professor, ossia «vedendo il bene dell’impresa e delle persone come un tutt’uno». Perché ciò possa avvenire, serve però anche maggiore creatività, da una parte, ma anche dare vera fiducia ai propri collaboratori.
A pensarci bene, rimarca Coda, «la richiesta di una migliore qualità della vita è formidabile», ma per andare in questa direzione ci vuole «un grosso irrobustimento della formazione dei responsabili HR», sottolinea ancora, perché per avere persone profondamente ingaggiate servono «inventiva e innovazione».

Alla incoraggiante prospettiva suggerita dal professor Coda risponde con gentile provocazione Ali Reza Arabnia, Chairman & Ceo di Gecofin Spa, oltre che Presidente Isvi e coordinatore nazionale dei Cavalieri del Lavoro Automotive.
Le grandi dimissioni hanno coinvolto anche il settore in cui il Ceo ha speso una vita intera, un problema che li ha costretti a chiedersi che cosa fare di più, considerando anche l’impegno speso in formazione. Arabnia si è chiesto in particolare come si possano tenere insieme le cinque generazioni al lavoro oggi, vista la difficoltà di trattenere in azienda soprattutto i più giovani.
A suo giudizio, occorrerebbe parlare chiaro, per esempio dicendo che non ci si può permettere troppo remote working: «Dire ai lavoratori che possono fare quello che vogliono è amorale», sottolinea il Presidente Isvi. Come uscirne? A suo avviso gli imprenditori dovrebbero tornare a «comportarsi come genitori, non come nonni». Tradotto in altri termini, ci deve essere reciprocità nell’impegno che ci si prende gli uni con gli altri.
Il punto di vista dell’imprenditore, diventato Ceo a soli 29 anni, è tuttavia solo all’apparenza duro: «Ai giovani voglio dire: non scoraggiatevi. Basta leggere un po’ di libri per capire che l’epoca che stiamo vivendo adesso è niente rispetto a quanto hanno vissuto i nostri padri. Il mio mi diceva sempre: quando tutti sono seduti, voi alzatevi». Insomma, dobbiamo solo «andare avanti», conclude Arabnia. Senza paura.
NEWS CORRELATE




